(di Irene Piccolo)

Nonostante un conflitto che ha creato la più grande crisi di rifugiati in Africa dal genocidio ruandese del 1994, le uniche notizie che arrivano in Italia sul Sud Sudan sono “solo” quelle che riguardano un aereo che cade con anche un italiano a bordo o qualche sud sudanese tra i migranti cui si accompagna automaticamente la domanda “ma perché viene fino a qui? Che starà mai succedendo in Sud Sudan?”.
1. Il Paese più giovane del mondo e la pace col vecchio Al Bashir
Il Sud Sudan conta circa 12 milioni di abitanti, grande quasi il doppio dell’Italia ed è il Paese più giovane del mondo, nato il 9 luglio 2011 dopo il referendum tenutosi nel gennaio dello stesso anno e che, con il 99% dei voti a favore dell’indipendenza, ha sancito il nuovo inizio per questa porzione di mondo. A differenza del Sudan da cui si è staccato, Paese desertico, etnicamente arabo e di religione musulmana, il Sud Sudan è piovoso e (era) fertile, la sua popolazione è subsahariana dalla pelle molto scura, l’Islam non ha mai attecchito e sono tutti di credo animista o in minor percentuale cristiano.
Al referendum e, dunque, all’indipendenza pacifica si era giunti dopo decenni di guerra, prima con la c.d. ribellione di Anya-Nya (1963 – 1972), e successivamente, dal 1983 al 2005, con la guerra ad alta intensità tra il governo sudanese e i ribelli del Movimento di liberazione popolare. Il 9 gennaio 2005 fu firmato l'accordo di pace tra le forze del Nord e del Sud Sudan (Comprehensive Peace Agreement – CPA) che prevedeva la convocazione di un referendum sull’indipendenza da organizzarsi non oltre sei anni dalla firma del trattato.
Tuttavia, già all’indomani dell’indipendenza, le tensioni interne hanno iniziato a creare instabilità nel neonato Stato, soprattutto a opera dei due principali gruppi ribelli (SSDM/A e SSLM/A), appoggiati dal governo del Sudan, con cui il Sud Sudan continuava a confrontarsi militarmente lungo le aree di confine. Basti pensare che nel solo 2011, dunque l’anno stesso dell’indipendenza, il bilancio fu di 1.400 vittime.
Il 4 gennaio 2013 il presidente sudanese Omar al-Bashir e quello sud sudanese Salva Kiir si sono incontrati in presenza del primo ministro etiope e del presidente sudafricano e, nonostante un’iniziale intenzione di rispettare le diverse scadenze in tema di sicurezza, confine e petrolio, l’incontro si è concluso senza alcun accordo circa la zona demilitarizzata tra i due Stati. A ciò si accompagnava l’accusa, nei confronti di Kartoum, di voler intraprendere "una guerra economica" con il Sud Sudan. Le trattative tuttavia proseguono e portano a un accordo di massima (8 marzo 2013) che rafforza la sicurezza del confine, prevede la creazione di una zona di confine smilitarizzata, l'assegnazione delle operazioni di verifica e controllo della frontiera nonché l'attuazione dei meccanismi di attivazione a partire dal 10 marzo 2013.
Su questo trend positivo si pone la visita a Juba, il 12 aprile 2013, di Al Bashir per la prima volta dall'indipendenza del Sud Sudan, per giungere a fine aprile alla firma di un accordo, che prevede:
- apertura e riapertura di 10 corridoi di frontiera;
- costituzione di un comitato congiunto di sicurezza (JSC) per facilitare il processo decisionale, rispondere alle richieste dei ribelli e promuovere le relazioni bilaterali e decidere su altre controversie.
Nel settembre 2013 c’è l’incontro decisivo tra Kiir e Al Bashir, in cui quest’ultimo ritira definitivamente la minaccia di vietare il passaggio del petrolio proveniente dal Sud Sudan in territorio sudanese, seguito nello stesso mese dall’accordo per l’apertura delle frontiere commerciali siglato dai rispettivi ministri degli interni.
2. Scoppia la guerra civile
Paradossalmente è proprio l’accordo raggiunto con il Sudan che creerà i presupposti per l’accendersi del conflitto interno. Difatti, il 23 luglio 2013 Salva Kiir scioglierà il governo e sospenderà sia il vice Presidente sia il segretario generale del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan (SPLM), Pagan Amum, che allora ricopriva la carica di Ministro per la Pace, accusandolo di cattiva gestione del partito e incitamento alla violenza. Si giunge dunque a una nuova composizione governativa, di 20 ministri, dopo aver consultato i leader di ben 17 partiti politici.

Questo rimescolamento rivela in realtà le tensioni interne al partito di governo e tutto ciò si trasforma, il 15 dicembre 2013, in un colpo di stato promosso e attuato dai soldati fedeli all'ex vice presidente Riek Machar. Gli scontri, a Juba, Alto Nilo e Bor, precipitano in un conflitto che rischia di trasformarsi in una guerra tra etnie e provocano migliaia di morti, circa 180.000 persone allontanate dalle loro case e 75.000 rifugiate presso le basi della Missione Internazionale delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) già presente nel Paese. Questo induce il Consiglio di Sicurezza ad adottare all'unanimità la risoluzione 2132 (24 dicembre 2013) che prevede un aumento temporaneo delle forze della Missione, l'immediata cessazione delle ostilità e, infine, autorizza l'uso della forza ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
Già all’inizio del 2014, i combattimenti a Bor, Malakal, Bentiu e Juba, Malakal, portano il numero delle persone sfollate a 494.000 e a 86.100 quelle fuggite nei paesi confinanti, spingendo dunque il Consiglio di Sicurezza a schierare 5.500 militari (arrivando a un totale di 140.000).
Il cessate il fuoco firmato da rappresentanti di Kiir e Machar ad Addis Abeba (23 gennaio 2014) dà una flebile speranza per la cessazione delle ostilità che però verrà disattesa dopo due mesi di negoziati rivelatisi inutili. Si realizza invece il fenomeno opposto, ossia un’escalation di atrocità anche a opera delle forze ribelli. Queste ad esempio, tra il 15 e il 17 aprile 2014, dopo aver riconquistato la città di Bentiu, compiono nei confronti di civili disarmati feroci massacri, incitati dalla diffusione radiofonica di discorsi di odio che riportano la memoria indietro di venti anni al massacro del Ruanda, nonostante gli appelli all’unità e alla fine del tribalismo da parte di alcuni comandanti, polarizzando ulteriormente lo scontro etnico.
Il cessate il fuoco è di fatto ripetutamente violato, provocando nei primi sei mesi di conflitto l’allontanamento di circa 80.000 persone e inducendo il Consiglio di sicurezza a prolungare il mandato di UNIMISS fino al 30 novembre (ris. 2155 del 27 maggio 2014).
Nell’agosto 2015 verrà firmato un accordo di pace, sotto la pressione delle Nazioni Unite, che nell’aprile 2016 portò all’istituzione di un governo transitorio di unità nazionale ma tre mesi dopo l’intesa venne infranta dalla ripresa dei combattimenti.
Ad oggi il conflitto ha fatto oltre 300.000 morti e spinto oltre 4 milioni di persone a lasciare le proprie case (1,9 milioni sfollati all’interno del Paese e 2,1 milioni che hanno espatriato).

I punti su cui vogliamo focalizzarci in questo scritto sono essenzialmente quattro:
- da un lato una concausa dell’acuirsi del conflitto interno, ossia la questione petrolifera (1);
- dall’altro lato, tre conseguenze del conflitto:
(2) la carestia, giacché ad oggi circa il 60% dei 12 milioni di abitanti sudsudanesi soffre di denutrizione;
(3) gli atroci crimini commessi che rischiano di evolvere in vero e proprio genocidio anche a causa dell’utilizzo distorto dei media;
(4) le migrazioni, anche verso l’Europa.
3. Questione petrolifera: chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane

Sebbene il sottosuolo del Sud Sudan sia ricco di molte materie prime (ad es. oro, rame, zinco, uranio, diamanti, tungsteno), il Paese è molto dipendente dal petrolio, che costituisce la quasi totalità delle sue esportazioni (95%, dati al 2009) e il 60% del PIL. L’americana Chevron aveva iniziato le prime esplorazioni negli anni ’80, ma rinunciò all’affare per via delle continue aggressioni da parte del Sudan People’s Liberation Army/Movement (SPLA/M). Così, nel 1992, Chevron cedette concessioni di esplorazione ed estrazione del greggio e ad oggi il quadro vede una forte presenza della francese Total. Tuttavia il dato che più fa riflettere è il fatto che la gran parte dei pozzi sia in mano alla China National Petroleum Corporation (CNPC).

I cinesi si sono aggiudicati queste risorse offrendo in cambio al governo di Kartoum la costruzione delle necessarie infrastrutture (raffinerie, strade e oleodotti) nel nord del Sudan unitario (ora solo Sudan) nonché – secondo alcune fonti – in cambio di armamenti per sedare le rivolte del Sud e impedirne l’indipendenza. Basti pensare che il governo sudanese era infatti il quarto esportatore mondiale di petrolio a beneficio di Pechino.
La gestione e lo sfruttamento delle risorse petrolifere erano stati al centro degli scontri tra Sudan e attuale Sud Sudan, essendo i giacimenti presenti solo nel sud del Paese ma le infrastrutture per la raffinazione, il trasporto e la vendita sono state realizzate solo nel nord del Paese. Come mostra la cartina, dunque, la maggior parte dei giacimenti si trovano adesso in Sud Sudan ma quest’ultimo non ha le capacità logistiche per sfruttare al meglio le risorse energetiche di cui dispone. Ne consegue che l’accordo raggiunto con Al-Bashir nel 2013 fosse un ottimo punto di partenza per la novella economia sudsudanese.
Tuttavia, una volta conclusasi la lotta contro il tiranno di Kartoum, sono iniziate le lotte intestine tra le tribù sudsudanesi; difatti – se si presta attenzione alla cartina supra di Relief web – gli scontri, eccezion fatta per la capitale Juba, si sono verificati solo nelle aree in cui sono presenti giacimenti petroliferi. Ci si è pertanto resi conto che non si tratta più di Dinka contro Nuer, ma di gruppi di potere più ristretti (incluse bande di criminali e delinquenti di ogni tipo) che combattono per il petrolio e il controllo del territorio.

Del conflitto ha naturalmente risentito tutta la situazione economica del paese: la produzione di petrolio è diminuita passando dai 245 mila barili al giorno di prima dell’inizio della guerra civile del 2013 ai 160 mila. Il PIL che, come si vede in questo grafico del Fondo monetario internazionale, era cresciuto rapidamente dopo l’indipendenza, dal 2015 è crollato. Nel 2017, l’inflazione è stata al 370% e la maggior parte delle entrate è stata utilizzata dal governo per la sicurezza, ossia per finanziare la guerra in corso.
4. “Oggi la carestia non è mai unicamente un disastro naturale, è sempre un prodotto di scelte politiche”
Oltre al posizionamento geografico del Sud Sudan, che si inserisce all’interno di quella fascia subsahariana chiamata Sahel la quale si sta progressivamente desertificando, a dare un colpo al cuore all’agricoltura sud sudanese è stato il conflitto in corso dal 2013. Difatti, molti uomini si sono arruolati lasciando alle donne la gestione dei campi e l’economia dei villaggi. Al contempo, i maschi che non si sono arruolati sono stati spesso uccisi nelle incursioni che le varie milizie facevano nei villaggi colpevoli di non essersi schierati per nessuno o a favore della “parte sbagliata”. In entrambi i casi, vi è stato un abbattimento della forza lavoro nei campi che non ha potuto dunque fronteggiare in alcun modo alla progressiva desertificazione del suolo.

Nel febbraio 2017, per la prima volta dal 2011, è stato nuovamente usato il termine carestia: la seconda volta da quando le Nazioni Unite hanno adottato la scala Ipc, una valutazione scientifica dei livelli di insicurezza alimentare. 1,1 milioni di persone vivono in aree dove si registra una situazione di “emergenza”, uno scalino sotto la carestia, e dove comunque ci sono persone che muoiono per la fame.
In tutto il Sud Sudan, secondo le Nazioni Unite, circa 250.000 bambini al di sotto dei cinque anni soffrono di grave malnutrizione, e probabilmente moriranno in mancanza di un intervento.
Nel 2017 5,8 milioni di persone dipendevano da aiuti alimentari, che tuttavia non sempre sono giunti a destinazione. Difatti, spesso il governo si è dimostrato determinato a ostacolarne la consegna o attraverso espliciti rifiuti (ben 967, dal 2014 al dicembre 2016, secondo l’ONU) o tramite il rallentamento delle procedure. Alla base di tale comportamento ci sarebbe il timore che quegli aiuti potessero finire, anche per sbaglio, nelle mani dei combattenti nemici, che avrebbero potuto venderli per comprare armi; pertanto si accetta il rischio (certezza) che a morire siano bambini e civili innocenti.

Sebbene in Sud Sudan ci siano 17.000 soldati delle forze di pace, che ai sensi del capitolo VII della Carta ONU sono autorizzati a usare anche la forza per proteggere i civili, l’organizzazione è restia a criticare il governo che ospita la sua missione per evitare ritorsioni o addirittura l’espulsione dei suoi funzionari e operatori. La dichiarazione formale dello stato di carestia è stata probabilmente fatta anche per costringere il cambiamento delle regole di ammissione delle forniture di cibo da parte delle agenzie umanitarie (come avvenuto ad esempio nel 2011 in Somalia, per poter portare cibo alla popolazione che viveva sostanzialmente come ostaggio di Al Shabaab).
Ciononostante, questa è rimasta una speranza; d’altronde su questo Paese, nato a seguito delle pressioni politiche statunitensi, è stato addirittura impossibile per anni introdurre un embargo sulle armi o delle sanzioni contro il presidente Kiir. Tuttavia, dopo la bocciatura della proposta di risoluzione presentata presso il Consiglio di Sicurezza il 23 dicembre del 2016 (difatti, erano necessari 9 voti a favore, ma ve ne sono stati solo 7, pertanto le astensioni di Russia, Cina e Giappone hanno avuto un peso), la costante insistenza da parte delle Nazioni Unite nonché delle varie agenzie e organizzazioni umanitarie ha portato all’adozione della risoluzione 2428 (del 13 luglio 2018) che ha imposto l’embargo alla fornitura diretta o indiretta, vendita o trasferimento d’armi verso il territorio del Sud Sudan.
5. Fake news e crimini, tra genocidio e bambini soldato
Nel 2015 già l’Unione Africana (UA - organizzazione che raggruppa gli Stati africani) ha accusato, in un suo rapporto, sia il governo che le forze ribelli del Sud Sudan di aver commesso violenze particolarmente atroci nel corso della guerra civile. Una commissione di inchiesta creata nel 2014, guidata dall’ex presidente della Nigeria Olusegun Obasanjo ha trovato prove di omicidi, torture, mutilazioni, rapimenti di donne, stupri e anche di episodi di cannibalismo forzato, soprattutto contro civili non direttamente coinvolti nel conflitto. Nella sua relazione, l’UA ha detto di aver individuato gli autori delle violenze da entrambe le parti e che i crimini sono stati commessi a Juba, Bor, Bentiu e Malakal. Alcuni testimoni a Juba hanno parlato di civili costretti a bere sangue e a mangiare carne di persone che erano state appena uccise o bruciate. Il rapporto parla anche di alcune fosse comuni scoperte dagli investigatori.
Le Nazioni Unite, a loro volta, hanno più volte accusato il governo e i combattenti ribelli di aver commesso atrocità e crimini contro l’umanità; l’ultima denuncia risale al febbraio 2018 quando è stato pubblicato il nuovo rapporto (a questo link sono disponibili i vari reports realizzati dagli organismi ONU sul Sud Sudan) e rilasciato il seguente video:
A luglio 2018 è stato pubblicato dall’ONU un nuovo rapporto sui massacri avvenuti nello Stato di Unity e a settembre anche Amnesty ha definitivamente denunciato le violenze in corso nel Paese, parlando di civili uccisi deliberatamente, bruciati vivi, impiccati sugli alberi e investiti con veicoli blindati”, oltre che documentare violenza sessuale sistematica, stupri di gruppo, rapimenti di donne e ragazze, e uccisione deliberata di ragazzi e neonati maschi. Si veda in tal senso anche il rapporto 2018 di Human Rights Watch.
Le Nazioni Unite hanno definito il Sud Sudan come uno dei posti più pericolosi anche per gli operatori umanitari; difatti, almeno 83 persone sono state uccise dal dicembre 2013, di cui 16 solo nel 2017.
Uno dei crimini che indubbiamente sta flagellando il Sud Sudan è l’arruolamento e coscrizione di bambini soldato, che sono all’incirca 19.000 ad oggi (un incremento del 3700%, dunque, rispetto all’inizio del conflitto, quando erano “solo” 500). Tali numeri hanno fatto entrare di diritto il Sud Sudan nella “lista della vergogna” stilata dalle Nazioni Unite.

Fortunatamente, il 2018 sembra aprire spiragli positivi su questo fronte, giacché grazie all’impegno dell’UNICEF, molti bambini sono stati rilasciati dai gruppi armati sud sudanesi. Si è iniziato a febbraio, quando circa 300 bambini sono stati rilasciati a Yambio Town per tornare alle loro famiglie, o in centri di assistenza supportati dall'UNICEF; poi a metà aprile altri 207 bambini rilasciati a Bakiwiri. L’obiettivo è quello di vedere nel 2018 quasi 1.000 bambini uscire dalle file dei gruppi armati e nel frattempo UNICEF Sud Sudan richiede 45 milioni di dollari per sostenere il rilascio, la smobilitazione e la reintegrazione di tutti i 19.000 bambini nei prossimi tre anni.
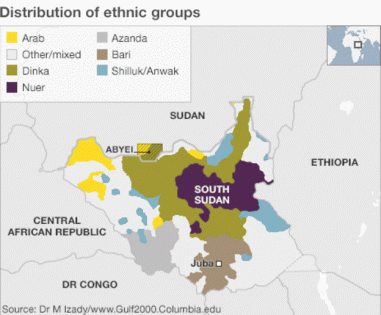
Alla denuncia di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra, si aggiunge la preoccupazione di intenti genocidiari su base etnica. Difatti, sono circa 64 le etnie in cui i sud sudanesi si riconoscono. E mentre prima erano tutti uniti nella lotta contro il “tiranno” Al Bashir, dopo l’indipendenza gli atavici odi interetnici sono tornati alla luce. La preoccupazione principale si rivolge in particolare verso i Nuer (cui appartiene il vicepresidente) per mano dei Dinka, l’etnia più numerosa in Sud Sudan (35,8% degli abitanti).
Intenti genocidiari che sarebbero alimentati anche attraverso i media, come già tristemente avvenuto nella vicenda di Radio Mille Colline che ebbe un ruolo significativo nel genocidio ruandese del 1994. Il fenomeno è così preoccupante che, il 15 dicembre 2017, il Consiglio di Sicurezza ha aggiunto tra gli incarichi dell’UNMISS quello di «monitorare, indagare e segnalare episodi di hate speech». È la prima missione di peacekeeping della storia ad avere anche un tale compito specificamente previsto nel suo mandato.
In particolare, oltre all’incitamento all’odio in senso generico, preoccupa ancor più nello specifico l’uso abbondante che si fa di fake news. Infatti, un rapporto preparato da un gruppo di esperti dell’ONU e diffuso a novembre 2017, ha spiegato che «i social media sono stati usati da esponenti di entrambe le fazioni, inclusi alcuni importanti funzionari governativi, per esagerare incidenti, diffondere bufale e minacce velate o condividere messaggi che incitano apertamente alla violenza», approfittando anche del fatto che la maggioranza delle persone che vivono in Sud Sudan non abbia un accesso a internet e il tasso di analfabetismo sia molto alto (circa il 70%). Ciò implica da un lato il monopolio dell’utilizzo dei social e del web in generale da parte di pochi, spesso gli stessi fabbricatori di bufale, che intercettano i pochi cittadini che hanno accesso a internet e poi questi tenderanno a parlarne con amici e conoscenti favorendo quindi il dilagare della diffusione offline della falsa notizia.
Con questo metodo sono stati fomentati molti episodi di violenza, spesso vere e proprie rivolte, ad esempio quella contro l’installazione di circa 4000 caschi blu nei pressi della capitale Juba. Difatti nel luglio 2017 il governo sud sudanese ha organizzato una campagna online contro tale stanziamento di truppe, dopo che i ribelli erano stati cacciati dalle forze governative con gravissime violenze che avevano causato la morte di centinaia di persone nonché lo stupro di circa centro donne. In quell’occasione, Ayuel Maluak Ayuel Atem, un giornalista del quotidiano filogovernativo National Courier, scrisse su Twitter e sul suo blog (dove si firma Chris Blakka) che i soldati dell’ONU avevano ucciso dei militari sud sudanesi sparando sul veicolo sul quale stavano viaggiando, e bruciandoli vivi. Altri giornalisti provarono a confermare la notizia, ma scoprirono che in realtà erano avvenuto l’esatto contrario e i soldati sud sudanesi avevano sparato contro un veicolo ONU, uccidendo due soldati cinesi e inducendo i caschi blu alla fuga.

Generalmente, si ingannano i lettori mascherandosi da fonti ufficiali, per esempio richiamando il nome di testate importanti o aggiungendo dei watermark a foto false, relative per esempio al genocidio in Ruanda (in Sud Sudan viene sfruttato soprattutto il logo dell’agenzia di stampa Associated Press). Plateale in questo senso è un gruppo Facebook antigovernativo che si è autoattribuito lo stesso nome, MirayaFM, della radio ufficiale della missione ONU (logo in questa foto) e pertanto faceva passare la notizia (falsa) di massacri avvenuti a danno di un’etnia come notizia ufficiale delle Nazioni Unite, incitando di conseguenza gli appartenenti all’etnia vittima del massacro a reagire.
In questo meccanismo, si sfrutta la c.d. echo chamber, cioè un ambiente in cui un’informazione viene propagata, ribadita e rafforzata senza che venga messa in discussione, il più delle volte offerta da quei gruppi facebook caratterizzati da un’ideologia politica o da un’identità etnica nei quali le notizie false vengono condivise e discusse. Se poi i gruppi includono membri di fazioni diverse, le discussioni sulle notizie, vere o false che siano, diventano spesso violente. Fanno dunque il gioco degli “influencer” che agiscono dall’estero e che sono perfettamente coordinati, al punto da riuscire a “darsi il cambio” da posti del mondo diversi per essere attivi 24 ore su 24. Generalmente sono persone originarie del Sud Sudan, seppur residenti all’estero; ma alcuni ricercatori ritengono che possano far parte di reti finanziate e organizzate esattamente per diffondere notizie false e incitare all’odio.
6. Una delle migrazioni più grandi di sempre e la particolare posizione d’Israele
La maggior parte di coloro che hanno lasciato il Sud Sudan ha trovato rifugio in Uganda: nel solo 2016 ben 490 mila profughi (per comprendere la portata del flusso migratorio basti pensare che in tutta Europa, lo stesso anno, son giunte 362.000).


In questo contesto, significativo è notare il comportamento particolare di Israele, il quale è uno dei punti di destinazione di molti profughi sud sudanesi. Difatti, quelli che non trovano rifugio nei Paesi limitrofi, risalgono il Sudan e l’Egitto, e a quel punto si presenta una biforcazione: o verso est, direzione Israele, o verso ovest, direzione Libia con destinazione ultima l’Europa.

Ebbene, attualmente in Israele vi sono 42.000 africani, di cui la maggior parte provenienti da Eritrea e Sud Sudan. Pur essendo uno dei firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951, il trattamento che Israele riserva ai profughi non è dei migliori, giacché sono ospitati nelle aree più povere a sud di Tel Aviv o rinchiusi nel carcere di Saharonim (appositamente costruito nel 2012 e considerato il più grande centro di detenzione di migranti al mondo), nel deserto del Negev. Un carcere in cui i detenuti hanno protestato spesso, con scioperi della fame, contro la loro incarcerazione e le condizioni di vita all’interno del carcere, non ottenendo alcun risultato.
Negli ultimi anni il governo israeliano ha inviato numerose notifiche di respingimento agli africani, ponendoli di fronte alla scelta se rimanere a vita nel carcere oppure accettare una modesta cifra e trasferirsi in Ruanda o Uganda. In circa 4.000, tra dicembre 2013 e giugno 2017, sono stati trasferiti in Ruanda e Uganda in base a un “programma di rimpatrio volontario” scoprendo però, una volta giunti nei Paesi di destinazione, che con questi non era stato stipulato alcun accordo bilaterale: i migranti non ottennero, di conseguenza, nessun documento di soggiorno né alcuno strumento per adattarsi alla loro nuova vita e iniziarono a percorrere la rotta libica.
Per ovviare a ciò, l’UNHCR ha cercato di inserirsi in questo meccanismo proponendo al governo israeliano un accordo, in base al quale l’agenzia ONU avrebbe trasferito 16.250 rifugiati africani in Paesi occidentali come Canada, Germania e Italia, in cambio della concessione, da parte di Israele, dello status legale temporaneo a un numero equivalente di profughi. Il 2 aprile di quest’anno, però, Netanyahu ha dichiarato di non avere più intenzione di siglare quest’accordo.

Alla base di tale comportamento vi è la contrarietà israeliana a creare un’integrazione di lungo periodo degli africani nel tessuto sociale israeliano. I migranti perciò sono considerati accettabili se si fermano per brevi periodi e fanno lavori sottopagati, ma sono assolutamente inaccettabili se cercano di ottenere i documenti necessari per restare nel paese.
La situazione risulta paradossale se si pensa che Israele è uno dei fornitori principali di armi e affini (es. droni, sistemi di comunicazione, fucili d’assalto, cannoni e veicoli corazzati) al continente africano - secondo l’Istituto internazionale di ricerca per la pace di Stoccolma (Sipri) -, con un incremento delle forniture del 70% tra il 2015 e il 2016. Tra i Paesi che hanno comprato da Israele figurano Angola, Camerun, Etiopia, Nigeria, Ruanda e Senegal; ma anche il Sud Sudan, sia i ribelli sia il governo. Si pensi che l’arma più diffusa in Sud Sudan è il fucile Micro Galil ACE di fabbricazione israeliana (conosciuto nello stato dell’Alto Nilo come Galaxies). Nel 2016 un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha presentato un rapporto molto critico rispetto al ruolo dei commercianti d’armi israeliani ed europei nel conflitto.
7. Pace (quasi) fatta
Nel 2018 sono stati avviati colloqui di pace più concreti, anche grazie all’impegno dei Paesi limitrofi interessati a condurre il Sud Sudan al termine del conflitto, in particolare l’Igad (Inter-governamental authority for development - Autorità intergovernativa per lo sviluppo) composto da Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Uganda, e di cui è presidente di turno il primo ministro etiopico Abiy Ahmed.
Ad aprile 2018 la Commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (Jmec), l’organismo per il controllo del cessate il fuoco in Sud Sudan istituito dall’Igad e presieduto da novembre 2015 dall’ex presidente del Botswana, Festus Mogae, ha annunciato il rinvio del secondo round di colloqui che però poi è stato ripreso nel corso dell’estate.
Il rinvio sarebbe stato deciso dopo che diversi partiti dell’opposizione hanno accusato i mediatori dell’Igad di aver ignorato le loro richieste, fra cui quella di far prendere parte ai colloqui il leader dell’opposizione armata, l’ex vicepresidente sud sudanese Riek Machar.
Ai 14 leader di opposizione voleva unirsi, in occasione del secondo round dei negoziati, anche il generale Paul Malong Awan, ex leader del Movimento di liberazione del popolo del Sudan ed ex Capo di Stato maggiore fino al maggio 2017 dell’esercito sud sudanese, un tempo tra i più stretti alleati del presidente Kiir, poi passato all’opposizione fondando il Fronte unito del Sud Sudan, e attualmente in esilio in Kenya. Malong, nel settembre 2017, era stato sanzionato dagli Stati Uniti per numerosi episodi di corruzione all’interno di un sistema di governo divenuto una “cleptocrazia tribale”, per aver ostacolato il riavvio dei colloqui di pace e boicottato le missioni umanitarie internazionali presenti in Sud Sudan. Il governo di Kiir si è comunque opposto fermamente alla sua presenza.
L’High level revitalization forum (Hlrf) ha tentato di riprendere l’accordo di pace del luglio 2015 nella plenaria ad Addis Abeba con una “proposta ponte“ che mirava ad allargare il governo e l’assemblea parlamentare spartendo la torta tra la fazione di Kiir (che sarebbe rimasto presidente), quella di Machar (che avrebbe ripreso il controllo della vicepresidenza) e altri gruppi di opposizione. Tutti i partecipanti hanno rifiutato la proposta, giacché la maggior parte dei componenti dell’opposizione richiedeva in particolare che:
- i 32 nuovi Stati del Paese siano sciolti e che la Nazione sia gestita con il vecchio sistema di governo;
- il presidente Kiir e il suo ex vice Machar si facciano da parte, cosicché il nuovo esecutivo di transizione sia guidato da una leadership diversa.
Questo episodio sottolinea che l’inclusività garantita dall’Hlrf – ossia il fatto che per la prima volta tutti i gruppi di opposizione hanno avuto voce in capitolo, al pari di società civile, giovani e donne – è il grande pregio del processo, ma anche il grande limite.
Il 20 giugno ad Addis Abeba, alla presenza del nuovo e attivissimo primo ministro etiope Abiy, Kiir e Machar si sono incontrati, il che ha avuto una grande importanza simbolica visto che non si vedevano da due anni. Il giorno successivo, al summit dell’Igad, si è affidato al presidente Al Bashir il compito di facilitare la mediazione diretta tra Kiir e Machar su temi quali governance e sicurezza, dandogli tempo fino al 9 luglio. A partire da tale data il compito sarebbe passato al presidente del Kenya, Kenyatta.
l Bashir, alla ricerca – oltre che di petrolio sudsudanese - di legittimità nella regione e in parte anche nell’ambito della comunità internazionale da cui non è ben visto per via dei crimini in Darfur, ha sfruttato la conoscenza diretta dei due litiganti, soprattutto del presidente Kiir che tra il 2005 e il 2011 era stato vicepresidente del Sudan.

Quest’opera di mediazione, avvenuta anche alla presenza del presidente ugandese Museveni (a testimonianza di quanto la pressione della regione a che si trovi un accordo sia cresciuta), ha portato alla firma - il 27 giugno di quest’anno – da parte di Kiir, Machar e altri gruppi di opposizione della Dichiarazione di Khartum, un accordo preliminare (in linea con l'accordo di pace naufragato del 2015) che prevede oltre a un immediato cessate-il-fuoco, anche l’adozione di disposizioni per costituire un esercito nazionale e la revisione della “proposta ponte” che formuli una nuova e condivisa spartizione del potere e un nuovo periodo di transizione fino ad elezioni. A ciò si aggiunge la “buona intenzione” di impegnarsi per fornire – con l’aiuto internazionale - alla popolazione martoriata dal conflitto tutti quei servizi ad oggi negati.
Tuttavia, come volevasi dimostrare, la parte più lunga e dettagliata dell’accordo riguarda la sicurezza dei giacimenti di petrolio al confine tra Sudan e Sud Sudan, i quali si impegnano a cooperare per la stabilizzazione e la ripresa a pieno regime della produzione.
Agli inizi di agosto, è stato fatto un accordo sul nuovo governo che prevede ben 5 vicepresidenti e 550 parlamentari (su 12 milioni di abitanti totali) distribuiti tra le varie forze, il che, in base alle prime impressioni, renderanno molto difficile qualsiasi azione di governo del Paese.
Nonostante il 9 agosto Machar avesse incassato l'amnistia per se stesso e i per i suoi, il 28 agosto ha lasciato il tavolo dei negoziati per ritornarci solo dopo un intenso lavoro dei mediatori dell’Igad e del ministro degli Esteri del Sudan, Ibrahim Ghandour. Finalmente, il 12 settembre è stato finalmente siglato un accordo di pace che, secondo molti, questa volta dovrebbe avere successo per una serie di buone ragioni pratiche, la prima delle quali è che questa volta l’intesa è stata raggiunta non con la forza come in passato. Inoltre, a suo favore giocano l’inclusività, già accennata, dell’iter negoziale, per cui più fazioni hanno avuto realmente voce in capitolo nel processo di pace a differenza delle volte precedenti. Infine c’è stato un impulso diretto nelle trattative da parte di ciascun membro dell’Igad, a dimostrazione del forte interesse regionale alla risoluzione del conflitto.
Tuttavia, la troika per il Sud Sudan, composta da Norvegia, Gran Bretagna e Stati Uniti, ha comunque delle perplessità dettate dal fatto che alcuni gruppi ribelli minori siano rimasti fuori dai negoziati.

Il giorno dopo la firma è cominciata una fase di pre-transizione di otto mesi che sarà seguita dalla vera e propria transizione che durerà tre anni, al termine dei quali dovranno tenersi nuove elezioni. Tutto questo dovrà portare alla ricostruzione vera e propria del sistema politico del Paese.
Secondo l’accordo:
- Salva Kiir rimarrà presidente e il suo principale avversario Riek Machar vice-presidente;
- un comitato sarà responsabile della delimitazione degli Stati federali, i cui territori verranno suddivisi su base etnica e tribale;
- il quorum deliberativo (ossia quello necessario a prendere decisioni) del Consiglio dei ministri sarà di 23 ministri, di cui 6 dell’opposizione;
- sarà creata una forza con soldati dei Paesi Igad per garantire l’applicazione del testo sul campo, dove vi sono ancora scontri nonostante il cessate il fuoco.
I prossimi mesi ci diranno se in Sud Sudan è davvero spuntata l’alba della pace.
